Taranto MArTA. Un pomeriggio raccontando Cesare Pavese con relazione di Pierfranco Bruni, video di Stefania Romito e letture di Marianna Montagnolo. Mercoledì 6 NOVEMBRE ORE 18.00. Introduce la direttrice Eva Degl’Innocenti.
“Entrai qualche volta da solo in cappella, nel freddo buio mi raccolsi e cercai di pregare…Uno che prega, quando prega è come sano”, da “La casa in collina”.
Il 29 gennaio 1944, su “Il Mestiere di vivere”, Pavese annotava: “Ci si umilia nel chiedere una grazia e si scopre l’intima dolcezza del regno di Dio. Quasi si dimentica ciò che si chiedeva: si vorrebbe soltanto godere sempre quello sgorgo di divinità. È questa senza dubbio la mia strada per giungere alla fede, il mio modo di esser fedele. Una rinuncia a tutto, una sommersione in un mare di amore, un mancamento al barlume di questa possibilità. Forse è tutto qui: in questo tremito del ‘se fosse vero!’. Se davvero fosse vero…”.
Ci sono attesa e speranza. È come se fosse un viaggiare alla ricerca di una salvezza, una salvezza cristiana! Tullio Pinelli, molto amico di Cesare, in una intervista a “Jesus” nel 1996 non tralasciò di dire: “Era uno spirito religioso, tormentato dal dubbio, dall’incertezza. Il punto terminale, su questa terra, della nostra discussione è stato sulla religione e su Dio”.
È naturale che l’attesa e la speranza hanno come punto di incontro, e quindi, come punto di riferimento, il senso del religioso. Inquieta l’attesa, ma è una dimensione spirituale che avvolge le nostre coscienze. Le coscienze del linguaggio. Il linguaggio dell’essere e del non essere. Il linguaggio che è spazialità di tempo dentro una visione che va chiaramente oltre il virtuale.
Sempre in “La casa in collina” Pavese annota: “… prima, passando davanti a una chiesa, non pensavo che a zitelle e a vecchi calvi inginocchiati, a fastidiosi borbottii. Che tutto questo non contasse, che una chiesa, un convento fossero invece un rifugio dove si ascolta con le palme sul viso calmarsi il battito del cuore?”. “…Mi soffermai presso la porta, poggiato alla fredda parete. C’era in fondo, sotto l’altare, un lumicino rosso…” .
Credo che la letteratura possa offrire una chiave di lettura importante e particolare del senso e dell’orizzonte che si vivono nella “stazione” di una spiritualità, che ha voce e destino. Siamo immensi nella letteratura. Siamo partecipanti del dolore che traccia un viaggio indelebile che è fatto dall’uomo e dalla persona. La letteratura parla con la parola della religiosità. Scriveva don Luigi Giussani: “Il senso religioso è la capacità che la ragione ha di esprimere la propria natura profonda nell’interrogativo ultimo, è il locus della coscienza che l’uomo ha dell’esistenza”.
Lo sguardo dell’uomo è lo sguardo, appunto, dell’attesa che, vivendola senza pazienza, potrebbe trasformarsi in disperante solitudine. Due concetti forti: la solitudine e la disperazione.
La ricerca di Dio. La memoria di Cristo. Vivono la letteratura nella letteratura. Don Giussani: “La forma quotidiana della decisione per l’esistenza è il ricordo del destino che ogni cosa ha, che è uno solo, il mistero di Dio, è il ricordo che questo mistero è diventato un uomo. Perciò, la forma quotidiana della decisione per l’esistenza è vivere la memoria di Cristo”.
Lo scavo della (nella) letteratura che trova attraversamenti su queste sponde porta direttamente a Cesare Pavese. Quel Pavese che ha vissuto e interiorizzato un dostoeschiano modello dell’inquieto esistere, e che non ha mai dato una ragione di senso alla morte sentita come attrazione della fine. Quel Pavese, in modo particolare, che ha chiesto, sino agli ultimi istanti di vita, di superare la solitudine in una parola di consolazione e di pazienza affinché potesse giungere un barlume di luce, di Grazia, di ancoraggi.
Pavese: “Passavo la sera seduto davanti allo specchio per tenermi compagnia”.
Don Luigi Giussani stabilisce proprio con Pavese un colloquiare e dice che è mancato in Pavese ciò che potesse colmare lo spazio inevitabile tra l’attesa e la pazienza. Quando questo spazio comincia a creare una strada nella vita e negli scritti di Pavese, la luce è diventata molto fievole e quella fede che lo avrebbe potuto salvare lo trova già disperso. Disperso e non smarrito. Disperso in quel gorgo muto che è l’inevitabile nulla. Ma Pavese portava nella sua parola e nel suo sguardo un senso religioso che diventa incisivamente pietas.
Diego Fabbri riesce ad interpretare, in teatro, un Pavese esasperato ma alla ricerca di Dio. Con uno splendido Luigi Vannucchi porta sulla scena quel suo mestiere di esistere che lo conduce verso uno scavo profondo che avrebbe dovuto condurlo ad una Verità. Una verità che non trova. Intorno al “Vizio assurdo”, lavorato con Davide Lajolo, si apre una brutta polemica innescata dal mondo marxista che non farà bene a Pavese uomo e tanto meno scrittore. Il laicismo trionfa, ma Fabbri, nonostante tutto, fa emergere, e per oltre quattro anni nei teatri e poi in Tv, un Pavese alla costante ricerca del sacro. Mito e sacro si combattono. È come se diventassero conflittuali. Pavese, in fondo, si ferma al mito e crea una antropologia del mito nonostante le pagine finali esemplare de “La casa in collina”.
Nel venir meno l’appiglio al religioso subentra l’abisso. O meglio non raggiungere il filo del sacro il vuoto si dichiara. E nell’abisso è scivolato pur tendendo le mani verso l’attrazione nei confronti della salvezza. In quale significato di non senso è precipitato Pavese? Eppure le sue ultime parole hanno un versamento che va oltre il nulla, e cercano di concentrarsi in un monito di ricerca di speranza.
Ho sempre cercato di individuare, nei miei scritti su Pavese, questo bisogno di speranza o la necessità della dissolvenza del nulla per aggrapparsi alla speranza che si sottolinea in molti passaggi dei suoi romanzi. Pavese, ho avuto modo di affermarlo, è sempre al limite della speranza – sacralità e poi giungono le distrazioni, le infinite distrazioni.
Don Giussani parla infatti di un venir meno di quella esigenza che è “la totalità dello sguardo dell’umana coscienza”. Anche nel religioso linguaggio dello scrittore ci sono delle opzioni tragiche. Ma ci sono opzioni religiose nel linguaggio e nell’essere tragico dello scrittore? Nel 1968 don Divo Barsotti, molto attento alla letteratura e al tragico, ebbe modo di osservare: “Pavese è stato consapevole di essere un vinto: ma da chi? L’impotenza a costruire una sua vita può essere stata la condizione, per lui, di abbandonarsi a Dio. Allora l’atto dell’abbandono avrebbe concluso la sua vita meglio di come egli poteva aver sognato”.
Pavese viveva la ricerca di Dio ma è andato oltre. Ecco: “La massima sventura è la solitudine; tant’è vero che il supremo conforto – la religione – consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio. La preghiera è lo sfogo come con un amico”.
In Pavese i due estremi di queste domande si sono scontrati creando un conflitto estetico ed esistenziale. Infatti, l’inquieto in Leopardi, don Giussani medita su ciò, non giunge a toccare il “gorgo muto” perché in Leopardi il senso del religioso non è così contrastante come nella vita di Pavese.
Tanto contrastante da diventare un cortocircuito tra destino e profezia. Così è stato il paesaggio trasgressivo di Pavese. Così Don Giussani: “L’estremo lembo dell’audacia è amare umilmente se stessi”. Il destino e la profezia. Nei suoi romanzi e nelle sue poesie ultime la consolazione giungeva sempre come solitudine. La solitudine era consolazione. Pavese si è posto le domande care a don Giussani: “… per che cosa vale la pena che io viva? Qual è il significato della realtà? Che senso ha l’esistenza?”.
Ha risposto a tali suoi interrogativi il Pavese sia del romanzo “La casa in collina” (religiosa attrazione verso il sacro) sia, soprattutto, il Pavese di “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” (penitente accoglienza della morte – fine).
I tuoi occhi? Quegli occhi che ha sempre cercato e che non ha trovato o non ha avuto la pazienza di aspettare quegli Occhi. Il rischio della pazienza consiste nel non saper raccogliere l’attesa nella speranza. Forse è qui che bisognerebbe scavare per dare un senso all’uomo e allo scrittore Cesare Pavese.
Oltre il mito e molto più vicini al sacro. Un viaggio che resta nei solchi del destino – memoria.
Nel Febbraio 1990 Padre Baravalle, in una sua conferenza a Milano, disse: “Io ero padre spirituale. Allora tutte le mattine raccoglievo i ragazzi della media, li portavo nella cappella del collegio. facevo dire la preghiera, facevo una piccola esortazione…Era una grande cappella. Era l’antico coro di un monastero. Pavese si metteva tutte le mattine di fianco, all’incirca a metà. E osservava i ragazzi. E io gli dico: ‘Perché viene? Io devo tare la predica a questi bambini e mi sforzo di far loro capire qualcosa’. E lui mi dice: ‘Vengo proprio a sentire come fa lei a cercare di rendere comprensibile a questi sventateVi, a questi ragazzi vivaci, le grandissime verità della sua religione’”. Mentre Pavese in una lettera a padre Baravalle scrisse: “Forse non sono degno di avvicinarmi a Dio”.
Ma è lo stesso Pavese che consegnò ai suoi “Dialoghi con Leucò” questo convincimento: “…gli uomini non sapranno il destino e saranno immortali….una volta che il grano e la vigna avranno il senso della vita eterna, sai che gli uomini vedranno nel pane e nel vino? Carne e sangue, come adesso, come sempre. E carne e sangue gronderanno, non più per placare la morte, ma per raggiungere l’eterno che li aspetta”.
Alla ricerca della religiosità, Pavese non cercava una antropologia di o in Cristo, bensì una fede verso Cristo. Un passo che lo avrebbe certamente salvato da quel taciuto silenzio e dal gesto finale. Ai primi di agosto del 1950 scriverà in una lettera a Pinelli e alla moglie : ”Invidio la vostra cristiana testardaggine. Vivete allegri e speriamo di rivederci, chissa’, magari in cielo”. La lettera di un Pavese alla ricerca della fede e di Dio è in questa disperante confessione.
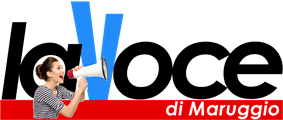 La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra
La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra 



