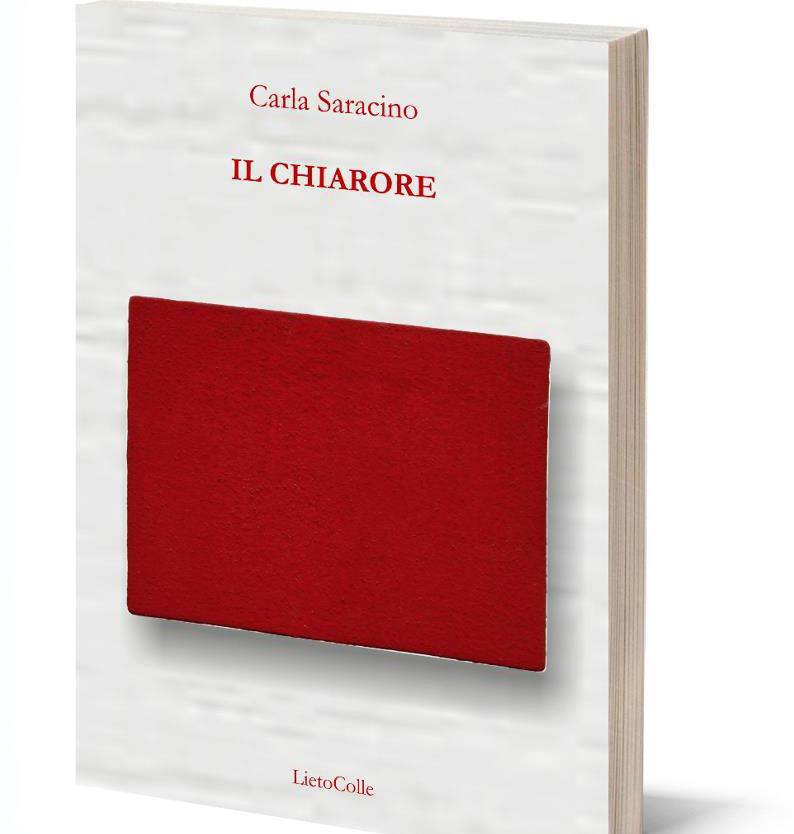 Dalla prefazione di Antonio Moresco.
Dalla prefazione di Antonio Moresco.
Come si fa a capire quando arriva un poeta?
Non c’è -non c’è mai stata- una tabella che possa indicarcelo con certezza.
Non c’è un codice (quelli che vanno per la maggiore sono in genere tarati sulla media poetica del tempo e sulle forze degli stessi poeti che li fanno propri e li generalizzano). Quanto ai piccoli recinti delle cosiddette poetiche e delle loro storicizzazioni, spesso servono solo ai poeti stessi quando hanno bisogno di collocarsi in rassicuranti spazi agonici e terminali sperando di renderli inoltrepassabili.
Non c’è un contatore in grado di registrare con esattezza l’intensità delle radiazioni della poesia.
C’è solo il gesto libero e impegnativo di chi prende la parola per dirlo.
Questa raccolta intitolata Il chiarore attesta, a mio parere, che è arrivato un poeta. Non solo un libro di poesie, ma proprio un poeta, un vero poeta, di elezione e di vocazione.
In molte delle poesie che si leggono in questi anni si può trovare eloquenza poetica. Qui invece c’è il cristallo della poesia:
“O io vorrei che questo accadesse nelle terre
di qualche Est superiore a quello pensato.
Qualche Est ricongiunto al cuore.
La punta dell’ordine, il chiarore.”
Abbassamento, disillusione, disincanto, mancanza di senso, caducità, finitudine, il disegno labile della realtà, contaminazioni… attraverso queste lenti culturali sono state lette in passato le caratteristiche esistenziali e artistiche di questa poetessa. A me -di questa nuova raccolta che segna un grande passo in avanti- arriva invece qualcosa d’altro. Arriva soprattutto una poesia piena, timbrica, affermativa, maestosa, inattuale, regale. Una poesia antica, ispirata, altera, di un poeta femmina e unica che è nello stesso tempo femminile e virile, innamorata della poesia che viene prima e che si mangia il mondo (Tu mi dirai: / sii il tuo mattino, / sii la tua anima). Una poesia desolata e fiabesca che ha il passo elegante di ciò che è ultimativo (Io penso che questo è l’ultimo fiato / che ricevi in dono dal primo giorno / e il migliore della tua alta felicità), resa per concentrazione di pensiero e intensità di illuminazione e visione. Una poesia in luce e proprio per questo piena di opacità e fissità, perché lo sguardo dell’anima è impenetrabile, fisso, perché ciò che è troppo vicino non lo si può vedere nitidamente, non se ne possono individuare i contorni, si può solo scorgere il vuoto che circonda i pensieri e le forme, senza il quale non sarebbe possibile cogliere il loro bagliore, la loro distanza che cresce man mano che ci si avvicina:
“Che male avvicinarti alla tomba
del mio nome riscritto dalla malattia
delle cose.”
“Sono nella perfetta forma di uno qualunque
dei miei doni.”
Carla Saracino è una poetessa del sud, viene da un mondo poetico e filosofico mediterraneo, ellenico e arabo-ispanico, come sembra suggerire il suo stesso cognome. Nella sua poesia vediamo balenare, con la straziante intensità degli attimi e dei sentimenti che non hanno ritorno nella luce, il tempo dell’attesa, il vivo focolaio della tempesta giovane, i caffè senza pace di provincia, le piccole stazioni, le spettrali bande di paese, le terre di brace, le nonne destinate ai fantasmi in spose, le città smeraldine, i palazzi d’oro, le apparizioni di portoni musivi e di arazzi trapassati nel mondo come lancia di sole a un tramonto verticale, le stanze d’albergo abitate tumultuosamente per una notte e poi abbandonate, i giorni in cui si finisce sconsideratamente a cenare in un paese, l’inganno della felicità e l’inganno del cuore, i cieli d’inchiostro e i giardini come piccole casse dentro cui morire, le donne che attraversano come sogni l’abbagliante buio del mondo e il suo fugace bagliore, il dolore che si espande nelle camere che si rifiutano d’essere, il triste fiore appuntato all’occhiello di un paese incenerito, i calici sollevati, le tavolate, le storie di ragazze mai morte, il turgore della vita in piena luce dietro il quale si indovina l’immobile vuoto e la vasta morte.
Questa raccolta è attraversata da accensioni liriche del tutto anomale nella poesia di questi anni:
“…e il ventaglio che da una veranda
di un paese di provincia
la gran dama dei palazzi di campagna sventolava per il caldo
afoso distribuito come cera sul fatale viso di femmina oltrelunare”
“Chi aveva dimenticato la storia?
Tutti, tranne il mio avo, che ancora s’aggirava serpentino
sotto le lucerne dei denti bianchi dei gelsomini
strafatti di polvere d’avvento.”
ma anche da zone di intensità ferma rese con il doloroso esercizio della sospensione meditativa e della sottrazione:
“Dovrei morire e solamente
accompagnare l’ultimo verso
dall’altra parte
della sponda fino a vederlo
salutare me e i miei privati
affetti, accumulati per ossessione
di felicità.
Niente è migliore del morire
fuorché la speranza di disimparare
a vivere.”
È una poesia di quelle che i nostri compilatori di poetiche postume dicono non più possibile, e che quindi adesso non dovrebbe esserci. Invece c’è. C’è chi non si domanda prima se si può o se non si può più fare la poesia, ma che la fa.
In questa raccolta si parla molto -direttamente o indirettamente- d’amore, visto nella sua faccia in luce e nella sua faccia in ombra. Dell’amore che si specchia nel disamore e del disamore che si specchia nell’amore. Esiste l’amore? Non esiste l’amore? I poeti lo sanno e non lo sanno. Dicono di saperlo ma non lo sanno, dicono di non saperlo ma lo sanno. Ma di sicuro sanno che alla fine è su questo che si gioca la poesia e che si gioca il mondo. Non la piccola poesia che sta dentro il mondo ma quella che contiene il mondo. Ai poeti (e alle poetesse) l’amore serve solo per stare dentro questa lacerante potenza che non sanno cos’è? Oppure è questa potenza che si serve dei poeti (e delle poetesse) per stare per qualche irrepitibile istante dentro l’amore e il suo lacerante chiarore?
Che cos’è l’amore in questa raccolta di poesia-poesia? Che cos’è questo apparente girare a vuoto che lascia dietro di sé le sue meravigliose metastasi come l’abbagliante coda di una cometa? Bisogna che la poetessa sia incapace d’amore perché la donna possa essere capace d’amore? O bisogna che la donna sia incapace d’amore perché la poetessa possa essere capace d’amore? E’ questo, nella nostra epoca, l’unico cerchio possibile per la poesia e per la letteratura? O questo cerchio si può sfondare?
Ho smesso di scrivere poesia in forma di poesia quando ero ragazzo, e non sono un critico di poesia. Ma sono convinto che non bisogna lasciare la poesia agli “addetti ai lavori” e ai suoi esecutori testamentari, tanto più in questa epoca in cui la poesia viene collocata in uno spazio morto, residuale e senza futuro. Mi è successo un’altra volta di sentire con forza la voce di un poeta italiano mio contemporaneo e di scriverne apertamente. E’ stato con Ivano Ferrari, un poeta di cui mi è arrivata immediatamente la voce dissonante e unica, la musica contratta e senza ritorno.
E poi mi è successo adesso.
E allora alla fine, tornando alla domanda iniziale, se qualcuno mi domandasse:
“Come fai a capire -nel gran numero di libri di poesie che escono in questi anni- che è arrivato un poeta? Come fai a essere così sicuro di poter riconoscere al primo sguardo la poesia?”
Gli risponderei:
“Perché sono un poeta anch’io”.
Nota Biografica
Carla Saracino è nata a Maruggio, in Puglia, nel Marzo del 1980.
Sue poesie sono apparse su varie riviste tra cui: Nuovi Argomenti, L’immaginazione e sull’Almanacco dello Specchio (Mondadori, 2010).
Ha scritto “I milioni di luoghi” (Lietocolle, 2007) che ha vinto il Premio Saba opera prima, “La Sposa Barocca AA.VV. (Lietocolle, 2010) e due libri per bambini, “14 fiabe ai 4 venti” (Lupo, 2009), “Gli orologi del paese di Zaulù” (Lupo, 2012).
Nel 2013 è uscito il libro di versi “Qualcosa di inabitato” scritto insieme a Stelvio Di Spigno (EDB Edizioni).
Scrive per la rivista letteraria “Le Voci della Luna”. Vive e insegna a Milano.
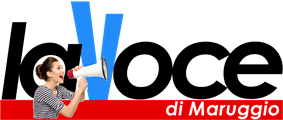 La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra
La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra




