Di livello e di grande interesse, l’incontro di conversazione di cultura fotografica, che sabato scorso si è tenuto presso l’ipogeo “Passo di Ronda”, in via Cava, nel cuore storico della città vecchia di Taranto. Organizzata dall’Associazione Fotografica 2.8 di Grottaglie, in collaborazione con “Timeline APS” e “I ragazzi del 25”, la tre giorni di fotografia prevista dal workshop “Obiettivo Storia”, giunto alla seconda edizione, ha offerto la possibilità di una riflessione ampia e dettagliata sulla figura, sulla forma e sul significato della fotografia di guerra, attraverso le parole di Domenico Semeraro, studioso e attento ricercatore dell’espressione artistica e comunicativa del mezzo fotografico, noto agli estimatori del campo per la sua particolare acutezza di visione artistica, pregna di volontà di conquista di potenzialità spaziali ancora inesplorate, di luoghi dell’arte oltre e dopo i pixel. Nelle immagini firmate da Domenico Semeraro, l’arte fotografica supera la bidimensionalità per divenire tridimensionale; il suo gesto apre la luce al buio e il buio alla luce. Una sorta di metafora dell’inconscio, quel luogo dell’anima, dove si nascondono tutti i pensieri più involontari. Ancora più efficace è l’equiparazione all’”extime” di Lacan, quel “luogo in cui l’interno è l’esterno e l’esterno l’interno, l’extimità”, uno strano mix di externo e intimità, una metafora, in ultima analisi, del senso profondo della persona e del suo essere nel mondo.
 Le fotografie di Semeraro sono sempre spunti di letture multiformi, sia per i vorticosi cambi prospettici, sia per quella potenza di visione che scardina e sovverte le consuete e, quanto mai logore, schematizzazioni di produzione fotografica, che inondano la web society. Ci sono domande, sempre; ci sono risposte, a volte. E’ questo il potere dell’immagine, catturare quell’attimo di vita che sfugge, per permettere di leggere quell’interrogativo profondo, che non si ferma alla denotazione, ma propone una connotazione che va oltre la superficie. Come ha scritto Milan Kundera nel suo romanzo capolavoro “Una domanda è come un coltello, che squarcia la tela di un fondale dipinto, per permetterci di dare un’occhiata a ciò che si nasconde dietro.” E come un Lucio Fontana dell’immagine fotografica, pronto a tagliare con una lama di luce la tela della realtà impressa su pellicola, Semeraro, nella sua presentazione, ha creato un ponte simbolico tra le varie epoche, nell’ambito della fotografia di guerra, ricordando che non si tratta di un genere, né una tecnica, neppure un vero e proprio mestiere, quanto piuttosto una condizione esistenziale, quella del soldato disarmato, che imbraccia un’arma che non “tira”, ma “prende”. All’inizio, sui campi di battaglia, gli operatori stipendiati, spesso, ebbero il compito, di mascherare quel che non era il caso di rivelare: Roger Fenton fu spedito in Crimea, nel 1855, dalla regina Vittoria per contrastare con la potenza delle “vere immagini” i cruenti racconti di William Russell, che comparivano sul Times e indignavano l’opinione pubblica di Sua Maestà, e mandò indietro foto di ufficiali in posa, tranquilli come a una scampagnata. L’orrore era accettabile solo come lontano esotismo barbaro, come appare nei reportage dell’italiano Felice Beato che, spostava i cadaveri lasciati per terra dal Great Mutiny indiano, per ottenere composizioni migliori. Erano nature morte di carne umana e, non potevano essere altrimenti, fino a quando le fotocamere erano totem di legno col treppiede, lenti e pesanti. James Hare, forse il primo fotoreporter di guerra moderno, si trascinava sulle spalle decine di chili di attrezzatura, inseguendo a Cuba l’evanescente conflitto ispano-americano, per scoprire a sua beffa che, intanto, la stampa di Joseph Pulitzer aveva già inondato l’America con immagini di guerra inventate dai suoi disegnatori.
Le fotografie di Semeraro sono sempre spunti di letture multiformi, sia per i vorticosi cambi prospettici, sia per quella potenza di visione che scardina e sovverte le consuete e, quanto mai logore, schematizzazioni di produzione fotografica, che inondano la web society. Ci sono domande, sempre; ci sono risposte, a volte. E’ questo il potere dell’immagine, catturare quell’attimo di vita che sfugge, per permettere di leggere quell’interrogativo profondo, che non si ferma alla denotazione, ma propone una connotazione che va oltre la superficie. Come ha scritto Milan Kundera nel suo romanzo capolavoro “Una domanda è come un coltello, che squarcia la tela di un fondale dipinto, per permetterci di dare un’occhiata a ciò che si nasconde dietro.” E come un Lucio Fontana dell’immagine fotografica, pronto a tagliare con una lama di luce la tela della realtà impressa su pellicola, Semeraro, nella sua presentazione, ha creato un ponte simbolico tra le varie epoche, nell’ambito della fotografia di guerra, ricordando che non si tratta di un genere, né una tecnica, neppure un vero e proprio mestiere, quanto piuttosto una condizione esistenziale, quella del soldato disarmato, che imbraccia un’arma che non “tira”, ma “prende”. All’inizio, sui campi di battaglia, gli operatori stipendiati, spesso, ebbero il compito, di mascherare quel che non era il caso di rivelare: Roger Fenton fu spedito in Crimea, nel 1855, dalla regina Vittoria per contrastare con la potenza delle “vere immagini” i cruenti racconti di William Russell, che comparivano sul Times e indignavano l’opinione pubblica di Sua Maestà, e mandò indietro foto di ufficiali in posa, tranquilli come a una scampagnata. L’orrore era accettabile solo come lontano esotismo barbaro, come appare nei reportage dell’italiano Felice Beato che, spostava i cadaveri lasciati per terra dal Great Mutiny indiano, per ottenere composizioni migliori. Erano nature morte di carne umana e, non potevano essere altrimenti, fino a quando le fotocamere erano totem di legno col treppiede, lenti e pesanti. James Hare, forse il primo fotoreporter di guerra moderno, si trascinava sulle spalle decine di chili di attrezzatura, inseguendo a Cuba l’evanescente conflitto ispano-americano, per scoprire a sua beffa che, intanto, la stampa di Joseph Pulitzer aveva già inondato l’America con immagini di guerra inventate dai suoi disegnatori.
 Due cose ci volevano per far nascere il fotogiornalismo moderno: fotocamere maneggevoli, e arrivò la Leica, e conflitti ideologici, dove fosse necessario schierarsi, e arrivò la guerra civile spagnola, dove Bob Capa e gli altri non erano altro che sovversivi internazionali armati di obiettivi, schierati con la Repubblica, consapevoli che le loro immagini sarebbero state politicamente usate per una causa. Prova generale della Seconda Guerra Mondiale, fu la vera guerra dei fotografi in divisa, armed with cameras, dove “essere abbastanza vicino”, il motto di Capa, significava avvicinarsi all’azione, ma anche alla motivazione. In quella guerra, le immagini finirono per essere testimoni d’accusa (anche letteralmente: a Norimberga), prove schiaccianti e determinanti di una vera e propria pedagogia visuale, incaricate di tracciare il discrimine fra buoni e cattivi, fra chi combatteva dalla parte giusta e chi no. Testimoni senza emozioni, voyeur dell’orrore, missionari dell’umanità, propagandisti del potere: è sottile e scivoloso il confine fra queste identità, perché la guerra va oltre le esperienze razionalizzabili della vita. Si è detto che furono le fotografie dal Vietnam a far finire la guerra in Vietnam o, più sensatamente, che fu la coscienza inorridita dell’America a cercare, nelle fotografie del Vietnam, le ragioni per alzare la voce contro la guerra. Ma, anche questo era destinato a finire. Arrivarono le guerre non-guerre, le guerre dentro le nazioni, dentro i popoli, dove capire era difficile e schierarsi impossibile. Le New War dell’era Bush tentarono il colpo di grazia ai reporter della visione. Niente fotografi fra i piedi. La prima Guerra del Golfo fu un affare di schermi televisivi verdastri con il logo Cnn, percorsi da scie luminose, niente esseri umani, una guerra simbolica, quasi un videogioco Nintendo. Non fu un buon affare: al Pentagono capirono che, lasciare l’opinione pubblica senza immagini vuol dire affamarla di spiegazioni e, in guerra, la ricerca di spiegazioni è pericolosa. Così, alla successiva, contrordine: da zero immagini a troppe immagini, censura per eccesso, un oceano di immagini. Ma, nuova svolta, anche i poteri forti non sono più padroni assoluti. La sfida ultima, forse letale, alla fotografia dei testimoni professionali è la guerra in autoscatto, che si ritrae da sola: la guerra selfie. I marines, che entrano a Fallujah, già avevano una videocamera montata sul casco. L’era dei fotocellulari è anche quella delle guerre che scoppiano nelle piazze, Tahir, Taksim, Gezi, Maidan, dove ogni insorto è un fotografo. Così diventa impossibile essere “molto vicino”, c’è sempre qualcuno, che è più vicino all’evento del professionista dello scatto. Spesso non è un testimone neutrale, ma fa parte del conflitto, sta da una parte di esso. Che fare, per i professionisti della visione? Cambiare la Nikon con l’iPhone, per confondersi, mimetizzarsi. Oppure andare ancora più vicino, correre nel cerchio di fuoco, in cerca dell’immagine che nessuno con lo smartphone saprà fare? Ma, il fuoco brucia e i fotoreporter muoiono sul campo.
Due cose ci volevano per far nascere il fotogiornalismo moderno: fotocamere maneggevoli, e arrivò la Leica, e conflitti ideologici, dove fosse necessario schierarsi, e arrivò la guerra civile spagnola, dove Bob Capa e gli altri non erano altro che sovversivi internazionali armati di obiettivi, schierati con la Repubblica, consapevoli che le loro immagini sarebbero state politicamente usate per una causa. Prova generale della Seconda Guerra Mondiale, fu la vera guerra dei fotografi in divisa, armed with cameras, dove “essere abbastanza vicino”, il motto di Capa, significava avvicinarsi all’azione, ma anche alla motivazione. In quella guerra, le immagini finirono per essere testimoni d’accusa (anche letteralmente: a Norimberga), prove schiaccianti e determinanti di una vera e propria pedagogia visuale, incaricate di tracciare il discrimine fra buoni e cattivi, fra chi combatteva dalla parte giusta e chi no. Testimoni senza emozioni, voyeur dell’orrore, missionari dell’umanità, propagandisti del potere: è sottile e scivoloso il confine fra queste identità, perché la guerra va oltre le esperienze razionalizzabili della vita. Si è detto che furono le fotografie dal Vietnam a far finire la guerra in Vietnam o, più sensatamente, che fu la coscienza inorridita dell’America a cercare, nelle fotografie del Vietnam, le ragioni per alzare la voce contro la guerra. Ma, anche questo era destinato a finire. Arrivarono le guerre non-guerre, le guerre dentro le nazioni, dentro i popoli, dove capire era difficile e schierarsi impossibile. Le New War dell’era Bush tentarono il colpo di grazia ai reporter della visione. Niente fotografi fra i piedi. La prima Guerra del Golfo fu un affare di schermi televisivi verdastri con il logo Cnn, percorsi da scie luminose, niente esseri umani, una guerra simbolica, quasi un videogioco Nintendo. Non fu un buon affare: al Pentagono capirono che, lasciare l’opinione pubblica senza immagini vuol dire affamarla di spiegazioni e, in guerra, la ricerca di spiegazioni è pericolosa. Così, alla successiva, contrordine: da zero immagini a troppe immagini, censura per eccesso, un oceano di immagini. Ma, nuova svolta, anche i poteri forti non sono più padroni assoluti. La sfida ultima, forse letale, alla fotografia dei testimoni professionali è la guerra in autoscatto, che si ritrae da sola: la guerra selfie. I marines, che entrano a Fallujah, già avevano una videocamera montata sul casco. L’era dei fotocellulari è anche quella delle guerre che scoppiano nelle piazze, Tahir, Taksim, Gezi, Maidan, dove ogni insorto è un fotografo. Così diventa impossibile essere “molto vicino”, c’è sempre qualcuno, che è più vicino all’evento del professionista dello scatto. Spesso non è un testimone neutrale, ma fa parte del conflitto, sta da una parte di esso. Che fare, per i professionisti della visione? Cambiare la Nikon con l’iPhone, per confondersi, mimetizzarsi. Oppure andare ancora più vicino, correre nel cerchio di fuoco, in cerca dell’immagine che nessuno con lo smartphone saprà fare? Ma, il fuoco brucia e i fotoreporter muoiono sul campo.
Correre nel fuoco per strappare quell’immagine che nessuno ha, che pochi vedranno, se non sarà premiata in qualche concorso fotografico per la catastrofe più fotogenica dell’anno. A rischio della vita, correre anche contro l’ipocrisia della società civile, che li accuserà di “spettacolarizzare” l’orrore, confondendo il testimone con il delitto, rimproverandolo per aver fatto, precisamente, quel che gli aveva chiesto di fare. Tra di loro c’è chi cerca la vita e non la morte; chi cattura la prima linea nei tratti della quotidianità e alle storie delle persone; chi usa la Reflex digitale per le riprese video e scatta con una Hasselblad 1965, ritratti in campo medio, mettendo sempre in relazione il personaggio al paesaggio e l’umanità al centro del contesto sociale in cui vive. Quel “terribile amore per la guerra”, da cui ci mette in guardia il filosofo James Hillman, come tutte le umane pulsioni, è affamato di immagini, non ne ha mai a sufficienza, non ne rifiuta alcuna. I fotografi di guerra più consapevoli capivano quanto fosse difficile, forse impossibile, produrre visioni della guerra, che non fossero per la guerra, figuriamoci contro la guerra. Toccarono con mano il conflitto straziante fra il dovere della testimonianza e il rischio della propaganda. La lotta dei fotografi con le insidie delle loro stesse immagini è una guerra dentro la guerra, che a volte ha travolge e uccide come la guerra vera. E con la simulazione di quella che prese il nome di “Operazione Husky”, ossia lo sbarco degli alleati in Sicilia, sulle spiagge di Gela, avvenuta nel luglio del 1943, che i partecipanti al workshop diventeranno fotoreporter sul campo per un giorno, nella giornata di domenica 22, potranno cimentarsi con l’esperienza diretta, mettendo in evidenza quei valori di efficacia della comunicazione visuale, espressi con l’uso della fotografia, intesi come determinanti plasmatori di una nuova forma di critica, strumenti in grado di far vedere in profondità, in grado di costruire quella sponda necessaria per comprendere e trasmettere.
Domenico Semeraro sottolinea quanto forte sia il filo che lega il racconto alla fotografia, nel senso che, sia il fotografo che lo scrittore di racconti scelgono un’immagine significativa, che funzioni come una specie di apertura verso qualcosa, che va molto oltre la foto o il racconto e che, il procedimento della rappresentazione e della narrazione, porti verso un aspetto importante e inatteso dell’esperienza (e della memoria), quello che Roland Barthes, nella sua opera “La chambre claire”, ha definito il punctum: “Non guarda nulla; trattiene dentro di sé il suo amore e la sua paura: ecco, lo Sguardo è questo”. Bisogna trovare questo sguardo, perché l’immagine possa essere l’intersecarsi di tre registri: il reale, il simbolico e l’immaginario.
Per la gentile concessione di Alessandra Basile su corriereditaranto.it
Per scriverci e segnalarci un evento contattaci!
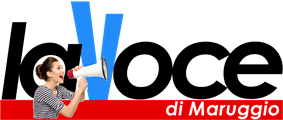 La Voce di Maruggio Libera Informazione in libera Terra – Notizie on line su Maruggio
La Voce di Maruggio Libera Informazione in libera Terra – Notizie on line su Maruggio




