
“La paura è umana, ma combattetela con il coraggio” (Paolo Borsellino)
Trent’anni fa. Strage di via D’Amelio. Palermo. Tragedia. Paolo Borsellino e tutta la scorta. Dopo Falcone, 23 maggio, e il dramma nella morte di esistenze tra salti di auto e schegge di vite il tempo si fermò sino al 19 luglio di 30 anni fa.
Era uno di noi. PAOLO BORSELLINO. Tradizionalista e cattolico. 19 luglio 1992, era di domenica. Sono trascorsi anni lunghi. La storia non fa mai sconti e le voci del destino sono, a volte, voci urlate in un deserto la cui sabbia è uno strappo di vento. Affiorano ricordi che sono ormai entrati nella memoria. Sono quei ricordi che mi costringono a pensare, a ripensare, a ripercorrere i silenzi che hanno accompagnato passaggi di vita.
Ho incontrato Paolo Borsellino al Sindacato Libero Scrittori. Era uno di noi. Molto amico di Francesco Grisi, di Giuseppe Tricoli, storico rappresentante della Fuan e più volte deputato regionale eletto nel MSI, di Tommaso Romano. Paolo è cresciuto in questo mondo. Un gruppo nella destra storica, tradizionalista e cattolica. Paolo aveva avuto radici nel movimento sociale italiano, quello di Giorgio Almirante e di Romualdi.
Diceva dopo la morte di Falcone: “Non sono né un eroe né un Kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa, non so quello che succederà nell’aldilà. Ma l’importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento… Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, potrei anche morire sereno.”
Era l’estate del 1992. Tra ritagli di articoli, mucchi di libri, pagine strappate mi imponevo di scrivere un romanzo saggio, ma più tomanzgeromanze che saggio, su un personaggio meta-invenzione di nome Cecilio Lutri. Un magistrato che cercava di ricostruire tutto il suo viaggio riassumendolo in una notte. Nelle ore brevi della notte. Di una sola notte. L’ultima. Una vita.
Perché in una notte? Perché era convinto che all’indomani sarebbe stato ucciso. E tra le vite e le storie che mi rimbalzavano nel mio immaginario c’erano tre nomi che non mi abbandonavano: Cesare Terranova, Rosario Livatino, il giudice ragazzino, e Giovanni Falcone, ucciso nel maggio di quell’anno.
Il mio romanzo aveva già un titolo ben stabilito dal mio editore. Quindi partivo da una traccia. Cosa che non ho mai fatto nella mia vita di scrittore. Avere già impostato il titolo e lavorare con i capitoli intorno a quel titolo mi rendeva tutto complicato. Ebbene il romanzo, che ebbe più edizioni negli anni, si doveva intitolare: “L’ultima notte di un magistrato”. Così si intitolò.
Tante interviste lette, tanti articoli che tagliavano a fette la mia formazione: da Enzo Biagi (nella sua intervista con il boss dei boss) a Sciascia (quel cattivo o incompreso articolo di uno scrittore come Sciascia che scivolò nell’ideologia di pessimo gusto: “I professionisti dell’antimafia”, pubblicato sul “Corriere della Sera”, uno Sciascia che non condivisi e che tuttora mi lascia perplesso.
In quel luglio di tanti anni fa scrivevo, dunque, un romanzo che doveva avere come filo conduttore la riflessione di un magistrato nella sua ultima notte. Il dibattito, intorno al tema dei rapporti tra politica e magistratura e politica e mafia, era molto pesante, soprattutto dopo la strage di Capaci. Anni lunghi, dicevo. Sì. E sono anni che ci separano dalla morte di Paolo Borsellino. Mio figlio aveva appena un anno e mia figlia soltanto nove. Con la mia Olivetti scrivevo pagine che poi cancellavo e riscrivevo. Mi dicevo: ci riuscirò prima o poi a dare un senso a Cecilio Lutri. Al personaggio del mio romanzo che doveva sintetizzare tanti percorsi e paesaggi umani.
Di Paolo Borsellino mi aveva parlato Giuseppe Tricoli, un docente universitario e un politico nel mondo del tradizionalismo di destra. Siciliano e conosciuto al Sindacato Libero Scrittori al quale era iscritto. Più volte ho incontrato Tricoli. Il 18 luglio del 1992 il mio libro era quasi a metà e cercavo di scriverlo come se fossero puntate da pubblicare su un quotidiano. Anzi, a dire il vero, nacque proprio così. Nacque, inizialmente, come idea di un lungo racconto da pubblicare nei mesi estivi su un quotidiano nazionale e doveva riempire un paginone settimanale. Mi trovavo in una villetta a Sibari, nel centro di quella che è stata la Magna Grecia. Mi trovavo nella mia terra, con il mio mare di fronte e il mio paese a pochi chilometri. Ma tutto il percorso di scrittura stentava.
 Dopo tante e tante letture e appunti su quaderni dalla copertina nera le parole cominciavano a scivolare e tra un immaginario fatto di percezioni, una fantasia che colmava i vuoti numerosi nel legare la mia scrittura onirica ad un realismo, al quale dovevo attenermi, la realtà di quei giorni mi dava una visione e una conoscenza che ha inquadrato subito la storia. “L’ultima notte di un magistrato”. Ma avevo sempre davanti a me le immagini di Livatino e Falcone.
Dopo tante e tante letture e appunti su quaderni dalla copertina nera le parole cominciavano a scivolare e tra un immaginario fatto di percezioni, una fantasia che colmava i vuoti numerosi nel legare la mia scrittura onirica ad un realismo, al quale dovevo attenermi, la realtà di quei giorni mi dava una visione e una conoscenza che ha inquadrato subito la storia. “L’ultima notte di un magistrato”. Ma avevo sempre davanti a me le immagini di Livatino e Falcone.
Il 19 luglio fu fatale nella tragedia che stavamo già vivendo anche sul piano politico. La strage di Via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino segnavano il disfacimento di storie. In quel momento compresi subito che dovevo snodare i miei nodi poetici ed entrare nel quotidiano, nella tragedia del quotidiano.
Borsellino l’ho sempre sentito vicino. Con la sua formazione culturale, con la sua forza da cristiano, con il suo coraggio e la sua lealtà. La sua morte cambiò il registro che mi ero imposto nello scrivere il romanzo. Anche se si sottolinea che personaggi ed eventi e riferimenti sono puramente casuali il tempo di quei giorni è nella realtà delle parole incise come solchi nella coscienza.
Davanti a quelle immagini viste in televisione e con le pagine che stavo scrivendo il mio sentire venne completamente lacerato. L’orologio aveva ormai le lancette spezzate. Il mio libro non uscì subito perché avevo la necessità di ripensare e di viaggiare tra i luoghi della Sicilia. In quella Sicilia dei mercati e delle strade invase da auto parcheggiate a spina, come in via D’Amelio.
Sono stato più volte a Palermo. Comunque diedi le pagine al giornale ma come articolazione narrante dovevo vivere e rivivere sensazioni, emozioni, incastrare destini. Di Paolo Borsellino mi parlò qualche mese dopo, in più occasioni, Giuseppe Tricoli, il quale scrisse una lunghissima recensione al mio romanzo pubblicato in prima edizione nel 1993, come testo complessivo e completo, e poi successivamente arricchito di altri capitoli. Quella tragedia ferì il mio non impegno degli anni precedenti e forse cambiò anche la mia vita di scrittore e di uomo. Sono passati anni lunghi e la foto di Paolo Borsellino mi accompagna, le parole di Paolo mi inseguono, i dialoghi con Tricoli ancora si intrecciano tra i miei anni. La sua morte è l’offesa alla civiltà dell’uomo. La Sicilia, la geografia del pianto, le mafie, i poteri che fanno rabbia e strappano umanità, le notti che seguono i giorni, le cicche delle sigarette lasciate a metà e consumatesi lentamente sono in quel mio tempo. In quel tempo che conobbi Paolo.
Cosa raccogliere dopo anni? Ci sono stati giorni di impazzimento, di spazi mai colmati, di stanchezze ma l’insegnamento di Paolo è sempre vivo nel nostro essere e nel nostro quotidiano: avere coraggio sempre e mai arretrare, non temere il rischio quando la vita è oltre il rischio.
Tra i libri che Paolo amava leggere c’era la “Storia di Cristo e delle origini del cristianesimo” di Pietro Cristiano Drago. Sono ritornato sui passi del mio romanzo “L’ultima notte di un magistrato” (edito da Il Coscile) e vi ho ritrovato una profonda malinconia. Non rileggo mai i miei libri. Ma questa volta l’ho fatto. E quegli uomini dei quali ho cercato di tratteggiare un segno, oggi più di ieri, sono la testimonianza vera di una umanità travolta dal sangue, sono i testimoni di un coraggio che non tutti hanno avuto e hanno, sono la fede non solo in uno Stato astratto ma la fede nella vita.
E Paolo Borsellino, cristiano aveva sempre come esempio, me ne parlava spesso Tricoli, ma anche lui stesso in quelle stanze del Sindacato in via IV Novembre, ma capivo profondamente Tricoli anche dai nostri incontri, (scomparso poi nel dicembre del 1995), la Croce e la Maddalena. In Borsellino c’è il tracciato della fede e dell’amore. Anni lunghi, dunque, nei quali ritrovo i segmenti di un pazientare e la forza di una rappresentazione in cui la volontà scava le rocce e il coraggio penetra gli animi.
Volontà e coraggio per Borsellino. In quei giorni, nel ricordo di quei giorni il mio camminare tra le parole è diventato possedere le parole. Non ho terminato il mio libro nella villetta di Sibari. Sono ritornato al mio paese dell’infanzia, nella grande casa della mia giovinezza che non dimentico, e lì ho cercato di fermare il silenzio e di dare voce alla tempesta che agitava la mia esistenza.
In quel mio romanzo Paolo Borsellino non è una tregua e non è neppure la pausa del “se” questo è un uomo, ma la fede che fa dire a Robert Brasillach, conosciuto e amato da Borsellino, proprio per la sua formazione culturale “… di conservare le due sole virtù alle quali io credo: la fierezza e la speranza”. Brasillach ritornava spesso nel suo pensiero e lo si nota in un suo appunto come questo: “È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.”
Sono simile alle parole doloranti di Tricoli che mi confessava nel dicembre del 1992 che in un suo diario aveva annotato delle riflessioni di Paolo che dicevano: “… la criminalità mafiosa… E sono ottimista perché vedo che verso di essa i giovani, siciliani e non, hanno oggi una attenzione diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni fino ai quarant’anni. Quando questi saranno adulti avranno più forza di reagire di quanto io e le mie generazioni ne abbiamo avuta”.
Ecco. Sono passati anni lunghi. Più antichi, più stanchi, più tristi? Ma la speranza è l’unica verità che potrà accompagnarci. Dal 19 luglio del 1992 altre generazioni hanno tagliato il tempo ma noi non siamo stati soltanto ad osservare. Dobbiamo continuare in una sfida quotidiana oltre il dolorante esodo. E Paolo che conosceva bene i valori e la dignità e le parole di Cristo ha depositato nei nostri cuori un testamento di lealtà e di amore nel coraggio di vincere sempre il male. “Non ho mai lasciato il mio impegno…” scriveva in una lettera ad un professoressa. L’impegno di essere uomini fino in fondo in una civiltà che ha bisogno di uomini veri.
Come tanti anni fa il giardino di casa ha le rose di luglio e i limoni hanno l’odore del Mediterraneo. I figli sono diventati adulti, i miei capelli sono brizzolati e quasi cadenti, il mio sguardo ha assenze tra il vento e la sabbia. Ho sfogliato appunti lasciati ai lati dei quaderni. Dopo la pubblicazione del mio romanzo sono stato chiamato in molte città e scuole a parlare di questo personaggio di nome Cecilio Lutri. Ho raccontato storie, ho inventato storie ma la forza di Borsellino è l’esempio che continua nella testimonianza di una vita. Una testimonianza che non si ferma. È diventata una immagine come testamento. La morte ci accompagna vivendo. Quella di Paolo è il testamento che si fa memoria e destino.
In quell’estate la mia Micol aveva 9 anni. Il mio Virgilio soltanto un anno. Ho scritto quel mio libro, il più delle volte, scrivendo tenendo sulle gambe Virgilio e raccontando la storia del giudice ragazzino a Micol. Sono passati anni. Annilunghi. Era di luglio. In quel luglio anche la politica e lo Stato, già agonizzanti, sono morti.
Pierfranco Bruni
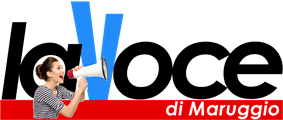 La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra
La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra 


