Conosciamo un po’ tutti virtù e impieghi delle fave come alimento: si tratta di un cibo popolarissimo nella antica alimentazione dei nostri paesi e nella tradizione contadina, tanto da aver fatto meritare anche ai savesi il soprannome di “Fungi & Fai”. Come alimento, questo vegetale facilmente coltivabile e dalla produzione generosa è rimasto popolare e di largo utilizzo, ma con il tempo se ne sono dimenticate le attribuzioni mitologiche e rituali tipiche delle antiche religioni, gli impieghi in medicina popolare, e nella magia (sia quella popolare e allargata, che quella più di stampo esoterico).

Ripercorreremo qui, brevemente, un po’ della storia degli impieghi alimentari, per poi arrivare a quelli medicinali, e alle credenze magiche, mitologiche e religiose intorno a questa pianta, e relativi usi e rituali.
Senz’altro si tratta di una pianta di antichissimo utilizzo, dal momento che le ricerche archeobotaniche dimostrano che nel periodo neolitico se ne faceva abbondante ed usuale coltura.
Oggi si consumano prevalentemente i semi di fave fresche o il purè, ma in periodo di guerra si cucinavano anche i baccelli e le cime tenere della pianta.
Oltre al consumo dei semi teneri e freschi (fave novelle), spesso accompagnato da formaggio fresco, vi erano tanti altri modi di utilizzo nella Puglia contadina e nell’area del Salento. La ‘ncrapiàta ad esempio era preparata mescolando il purè alla verdura lessa e condita con olio.
La muzzicatùra delle fave secche era un vero e proprio rituale eseguito dalle donne che ritmicamente le sgusciavano sedute davanti casa, battendole con un ciottolo sulla chianca. Una volta muzzicàti le fave erano lasciate a bagno e poi cotte alla pignata.
Le fave avanzate e consumate il giorno dopo riscaldate, venivano chiamate fai crisciùti o fai scarfàti.
Il tonchio della fava è un coleottero che depone le uova sui baccelli freschi; le larve penetrano all’interno e si insediano nei semi da cui poi fuoriescono alla fine del ciclo gli individui adulti. Questo coleottero ha un nome popolare nei nostri paesi, lu falaùru (varianti dialettali a seconda delle zone: fafarùlu, faraùlu, favalùru, fammarùlu, ecc.). A Taranto fafalùre è anche detta una persona che si intromette nei fatti degli altri (come il coleottero che si intromette nel baccello), mentre a Francavilla Fontana si giocava sull’assonanza dei nomi falaùru e savalùru per appellare ironicamente i savesi.[1]

Un altro nemico della fava è l’ Orobanche, una pianta parassita in dialetto chiamato spurchia che non a caso diviene anche sinonimo di sfortuna.
Le fave secche e crude erano mangiate per favorire la digestione e placare il mal di stomaco (in realtà un consumo smoderato può avere effetti opposti); poste con una certa pressione su una ferita, fungevano da emostatico.[2]
Un distillato di fave fresche svuotate dei semi, insieme a distillato di foglie di more, era utilizzato contro i calcoli.[3]
Costantini e Marcucci, nella loro ricerca sui rimedi popolari salentini, riportano di credenze intorno a poteri afrodisiaci delle fave.[4]
Il purè di fave era consigliato alle partorienti perchè si riteneva facesse fare latte.
Secondo Galeno le fave erano molto nutrienti e perciò le indicava come “la carne del povero”.
A Manduria si credeva che se si consumavano fave nel giorno di Santo Stefano, ci si sarebbe ammalati di frònchiuri (foruncolosi) per espressa punizione del santo, che non ammetteva tale pasto nel giorno a lui dedicato. Si tornava invece a consumarne (pur malvolentieri) a inizio Quaresima con il detto “Carniàli mia chinu ti uài, ieri maccarruni e osci fai”.[5]
“Li fài ti la prima mujeri” è un modo di dire che indica nostalgia; detti legati invece alla caratteristica di piatto dei poveri sono “fai e pisieddi alli purièddi” o “fatìa, fatìa, e la sera fai e cipodda” (ma anche “pani e cipodda”) mentre certamente più consolatorio è il detto “fai e cipodda e cori cuntientu”.
“Unguloni senza fai” è detto di una persona inutile o stupida o senza forze; “bbènchìulu ti fai e corculu” indica ugualmente persona stupida o inetta o senza interessi, così come “capu ti fai”; “mmiskàri fai e foji” sta per “fare confusione”; “lu tiempu passa e la fàa si coci” indica saper attendere, aver pazienza.
Vi sono detti legati anche alla semina, alla crescita e alla raccolta: “ti santu Leonardu chianta li fai ca jè tardu” (pianta le fave entro il 6 novembre, san Leonardo, che è già tardi); “acqua ti aprìli, unguli ‘ntra lu mantili” (pioggia d’ aprile, molte fave nel grembiule); “annata ti laùzzi, annata ti faùzzi” (quando ci son molti asfodeli, sarà anche annata buona per le fave).

Nella magia popolare locale erano utilizzate a scopo divinatorio per trarre previsioni sulle condizioni economiche del possibile futuro sposo: a Francavilla Fontana c’era l’usanza di porre tre fave sotto il cuscino e prenderne la mattina una a caso. La fava sgusciata prediceva povertà; quella priva del nasello agiatezza, quella con il tegumento ricchezza.[6] Analoga usanza è citata dal Cattabiani per i paesi del Gargano, in cui un rito identico a quello sopra descritto si faceva nella notte di San Giovanni Battista, mentre riti simili con leggere varianti sono attestati anche in varie zone della Sicilia.[7]
Associate al mondo dei morti, hanno sempre avuto fama ambivalente: si credeva che in esse risiedessero le anime dei defunti, e per questo potevano essere simbolo di sciagura e al tempo stesso cibo rituale in occasione della commemorazione dei defunti. [8]
Le fave erano utilizzate anche nelle pratiche magiche esoteriche: fanno parte difatti della composizione di un antico unguento finalizzato a “far apparire cose strabilianti”: in tale unguento, caratterizzato dalla presenza di Solanacee tropaniche (Belladonna, Datura e Giusquiamo, che sono i principali veicoli dello stato narcotico-allucinogeno provocato dalla mistura), le fave, utilizzate sotto forma di farina, hanno probabilmente il ruolo (secondo l’interpretazione del tossicologo Malizia) di rendere la pelle meno grassa e perciò più permeabile all’unguento. Gli ingredienti di tale mistura sono: mele, castagne, fave, ceci, cavolo, fagioli, belladonna, giusquiamo e stramonio.[9] Una mistura oleosa con la quale ungersi tempie e ascelle al fine di “sognare eventi straordinari” comprendeva: “giusquiamo, datura stramonio, belladonna, sedano, fave, papavero sonnifero, un’ombra di aconito”, preparati sotto forma di tisana.[10]
Le fave sono sempre state associate a molti tabù: ad esempio si riteneva che la dea Demetra le avesse escluse dalla sua sfera sacrale e ne avesse proibito l’utilizzo sia ai suoi sacerdoti che a chiunque partecipasse ai suoi riti.[11] Questo divieto si ritrovava anche tra gli orfici ed i pitagorici (Pausania riferisce che il motivo è “un sacro segreto”). In questo divieto si intrecciano molti curiosi significati esoterici, miti e simbolismi: la fava è considerata mezzo di comunicazione tra Ade e mondo degli uomini; cibarsene significa mangiare le teste dei propri genitori; una fava chiusa in un recipiente e sepolta nella terra o nel letame si trasforma dopo 40-90 giorni nella testa di un bambino, o di un uomo, oppure in un organo sessuale femminile, oppure ancora diventa sangue.[12]
Per i pitagorici le fave simboleggiano anche gli organi sessuali e ne hanno analoghe caratteristiche.
Si credeva anche che la fava fosse stato il primo essere vivente, e che fosse simbolo di mortalità contrapposta alla divinità.
Si credeva che mettendo al sole una fava rosicchiata, qualche ora dopo questa avrebbe emanato l’odore dello sperma o del sangue.
L’acqua in cui si immergeva un infuso di fave si tingeva di rosso, il colore del sangue, e anche per questo motivo la fava veniva associata al sangue. Tutte queste analogie con il sangue e con gli esseri umani impedivano ai pitagorici di mangiarne in quanto cibarsene, si pensava, era come se si mangiasse carne umana.
Le anime dei morti potevano prendere possesso di un essere umano attraverso le fave, loro veicolo. Si credeva inoltre che potessero danneggiare il corpo e la mente. Per Plinio la fava può intorpidire i sensi e provocare visioni. Così come le fave ingrassano il terreno, ingrassano il corpo dell’uomo; fanno gonfiare, si digeriscono a fatica, e provocano incubi (“fanno sognare cose paurose e terribili”, scrive il Mattioli).

La cattiva fama attribuita alla fava come vegetale che ottunde la mente, oltre ai vari altri tabù, la escludeva dai culti oracolari greci, tuttavia nei culti più arcaici gli oracoli erano svolti proprio adoperando le fave. Ma caratteristica degli oracoli precedenti in cui venivano impiegate le fave era il sorteggio, mentre gli oracoli greci erano basati su forme di consultazione della divinità non così casuali. Secondo il Cattabiani però sopravvivono alcune tradizioni, che si ricollegano al simbolismo più antico, sino, addirittura, all’impiego medievale delle fave per votare (la fava nera utilizzata per esprimere consenso e la fava bianca dissenso).[13]
Un impiego più recente delle fave in un gioco casuale e legato alla sorte, è nell’uso delle fave secche (e di altri legumi) per coprire i numeri delle cartelle della tombola.
Ritorna l’utilizzo delle fave per trarre auspici nella tradizione romana; viene utilizzata come strumento oracolare e come talismano, e, secondo vari autori, dà il nome alla gens Fabia.

Nella Roma antica, le fave appaiono spesso sia in riti propiziatori che in riti funebri. Una farinata di fave era offerta alla dea Carna, protettrice degli organi vitali dell’uomo, in occasione di una festa apposita. Queste feste si tenevano il primo di giugno ed erano chiamate Kalendae fabarie (Calende delle fave).
Nelle tombe dei morti si gettavano fave, che, grazie a quella che si credeva una loro componente fatta di sangue, davano energia ai defunti nel mondo degli inferi. Secondo il Cattabiani, il pasto funebre raffigurato in molti mosaici pavimentali romani, il silicernium, ha un suo corrispettivo e derivato nell’uso di cibarsi ancor oggi, in occasione della commemorazione dei defunti, di dolci a base di pasta di mandorle detti “fave”.[14] A Manduria e in altri paesi, una simile tradizione prevede l’impiego de li fai ti li muerti (le fave dei morti), dolcetti a forma di seme di fava, e fatti di mandorle, zucchero, burro, uova e vaniglia.[15]

L’ usanza tipica dell’ Italia centrale (ma anche del meridione) di mangiare fave e pecorino tra maggio e giugno è mutuata, secondo il Cattabiani, proprio dalla tradizione in onore della dea Carna (emanazione della Grande Madre).
Le fave nella antica Roma erano consumate anche il 21 febbraio nella festa dei Feralia, giorno conclusivo delle Parentalia (istituite in onore dei defunti della famiglia). In questa occasione si svolgeva un rito in onore della dea Tacita Muta che prevedeva anche il rigirarsi in bocca sette fave nere. Tacita Muta non è altri che Lara, una ninfa alla quale Giove ha strappato la lingua perchè “ha parlato troppo”: difatti Lara avvisa sia la sorella Giuturna che la moglie di Giove, Giunone, del fatto che Giove intende possedere Giuturna, rovinando così i piani al dio. Giove le strappa la lingua trasformandola in “Tacita Muta” e la affida a Mercurio che ha il compito di portarla negli inferi. Mercurio esegue l’ordine ma durante il tragitto abusa di Lara facendole concepire due gemelli, i Lari, che divengono le divinità dei crocicchi e delle case. Sia Tacita Muta (Lara) che i Lari sono dunque divinità delle soglie, del trapasso, degli inferi e della comunicazione con il mondo infero. I Feralia sono la festa del trapasso ma anche il passato su cui si fonda ciò che nasce. Simboleggiano anche il passaggio da un anno all’altro. Le fave hanno le stesse funzioni simboliche.
Le fave rituali ricompaiono nelle Lemuralia, le feste di maggio in onore dei Lemures, gli spettri che invadono il mondo dei vivi. I Lemures sono spiriti vaganti di persone morte precocemente, o con rimpianti o anzitempo, e sono per questo entità terrifiche che gli uomini devono placare. Il rito per propiziarseli, descritto da Ovidio nei Fasti, consisteva nelll’alzarsi dal letto a mezzanotte, far schioccare le dita rumorosamente tra pollice e medio, lavarsi le mani in acqua di fonte per purificarle, mettere in bocca fave nere e gettarle all’indietro dicendo (e ripetendo per nove volte senza voltarsi indietro): “le getto, e con queste fave me e i miei parenti redimo”.[16] Si credeva che l’ombra (spiega lo stesso Ovidio), raccogliesse le fave senza essere vista. Nuovamente, ci si doveva purificare con l’acqua, battere recipienti di bronzo e pregare che quell’ombra uscisse dalla casa, ripetendo per nove volte: “uscite, Mani paterni”.[17] A questo punto ci si poteva voltare e il rito era terminato.
Ho descritto in altre occasioni i substrati mitologici e antichi sui quali si fonda e si rimodula la nostrana credenza del Laùru, lo spiritello salentino delle case, genietto funebre e notturno, che si credeva essere lo spirito di un antenato o parente morto di morte precoce o improvvisa[18]: si noti sia l’assonanza etimologica con le figure descritte sopra (Lara, i Lari, i Lemures – detti anche Larve) che “caratteriale”. Ma le fave, come si è visto, oltre alla funzione di placare ritualmente i morti e di essere simbolo e veicolo di comunicazione tra il mondo dei morti e quello dei vivi, hanno anche quella di provocare (come affermano Plinio, il Mattioli ed altri) incubi, visioni, far sognare “cose spaventevoli e terribili”. Le abitudini alimentari alle fave e la pesantezza a livello di digeribilità dell’alimento stesso (a tutt’oggi è consigliato un consumo moderato per evitare i molteplici disturbi di cui possono essere causa) possono aver favorito, in un passato in cui si faceva un consumo costante e ripetuto nella giornata di queste pietanze, incubi e malesseri notturni che, innestati sulla radicata credenza nel Laùru, ne hanno “favorito” e alimentato la visione frequente.

Gianfranco Mele
- Domenico Nardone, Nunzia Maria Ditonno, Santina Lamusta Fave e favelle, le piante della Puglia peninsulare nelle voci dialettali in uso e di tradizione, Centro di Studi Salentini, Lecce, 2012,Nardone et al. Pag. 240 ↑
- Domenico Nardone, Nunzia Maria Ditonno, Santina Lamusta , op. cit., pag. 242 ↑
- Salvatore Pezzella, Magia delle Erbe, vol. 1, pag. 77-78 ↑
- Antonio Costantini, Marosa Marcucci, Le erbe, le pietre, gli animali nei rimedi popolari del Salento, Congedo Ed., 2006, pp. 80-81 ↑
- Domenico Nardone, Nunzia Maria Ditonno, Santina Lamusta , op. cit., Pag. 240 ↑
- Domenico Nardone, Nunzia Maria Ditonno, Santina Lamusta , op. cit., pag. 242 ↑
- Alfredo Cattabiani, Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante, Mondadori, 1996, rist. 2017, pag. 487 ↑
- Nardone et al., pag. 238 ↑
- Enrico Malizia, Ricettario delle streghe, Edizioni Mediterranee, 2003, pp. 104-105 ↑
- Enrico Malizia, op. cit., pp. 105-106. N.B.: come sempre, e per quanto sia scontato, in riferimento a questa tipologia di documentazione ribadisco che notizie, i preparati e le ricette inserite in questo articolo hanno unicamente valenza documentaria etno-antropologica: non sono in alcun modo da considerarsi praticabili o sperimentabili. ↑
- Alfredo Cattabiani, op. cit., pag. 483 ↑
- Alfredo Cattabiani, op.cit., pag. 483 ↑
- Alfredo Cattabiani, op.cit., pag. 485 ↑
- Alfredo Cattabiani, op.cit., pag. 489 ↑
- Domenico Nardone, Nunzia Maria Ditonno, Santina Lamusta , op. cit., pag. 238 ↑
- Ovidio, Fasti, V, 429-444 ↑
- Ibidem ↑
- Gianfranco Mele, Maurizio Nocera, La Magia nel Salento, Spagine-Fondo Verri Ed., 2018, pp.12-17; vedi anche Gianfranco Mele, Alle origini del laùru, lo spiritello incubo, La Voce di Maruggio, sito web, novembre 2018 ↑
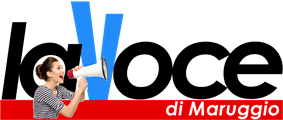 La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra
La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra 



