Non so se vi sia mai capitato di provare quella sensazione di desiderio mista a paura. Una sorta di volere e allo stesso tempo di timore per ciò che accadrà. Kundera parlerebbe di vertigine. Ciò che ci provoca quel vuoto nello stomaco quando siamo ad un’altezza elevata è il desiderio di cadere e la conseguente paura messa in circolo dal nostro organismo per proteggerci da una morte dionisiaca e insensata. Ecco questo senso di vertigine, di voglia di buttarsi e paura di cadere, questo, è quello che ho provato io per 5 anni nei confronti del teatro. Un desiderio riposto nel cassetto e rimandato all’infinito per l’aurea di timore vertiginoso che emanava. Quest’anno, il mio ultimo, ho preso coraggio e scacciato via i fantasmi della paura di mostrarmi nuda e disarmata in pubblico (per nuda intendo nuda nella mia anima ovviamente). Perché fare teatro non vuol dire solo, semplicemente e banalmente recitare una parte, ma calarsi in quella parte, diventare quella persona e provare sulla propria pelle il suo dolore, la sua gioia, avere le sue cicatrici e le sue rughe sulla fronte, segno tangibile di una vita e di una storia che l’attore ha vissuto e conosce come se fosse propria. Fare teatro vuol dire, nonostante possa sembrare un ossimoro, togliere via e sbarazzarsi di tutte le maschere, di tutte le convenzioni, di tutti i modi di fare prestabiliti che la gente ormai si aspetta da noi. È po’ come fuggire per un po’ dalla nostra pirandelliana prigione, è un po’ come una concessione dataci ad esprimere qualsiasi tipo di sentimento, qualsiasi, senza mai venir giudicati, perché per il pubblico quei sentimenti, quelle emozioni non sono nostre o come nostre non appaiono. Eppure lì sul palco davanti a tutti, quei sentimenti vibrano davvero sulla corda sottile e sensibile dell’anima dell’attore.
Ma ritorniamo a me e alla mia scelta e presa di coraggio. “L’uomo è ciò che mangia”! È questo il nome del modulo del progetto PON “Il futuro possibile” sullo sviluppo delle competenze di cittadinanza globali e delle competenze trasversali, che mi ha trasmesso la spinta giusta; un progetto finanziato dal Fondo Europeo che ha inteso affrontare non solo il secondo e terzo obiettivo dell’Agenda 2030 relativi all’alimentazione, ma anche e soprattutto uno dei problemi che attanagliano le giovani generazioni: quello dei disturbi del comportamento alimentare.
Un tema attuale, “pesante” nel senso di “avente valore”, delicato. È sottile la linea che nelle nostre menti complesse più che complicate separa l’essenza dell’intenzione da quella della percezione. Quante volte ci capita di fare qualcosa per qualcuno in un modo (intenzione) e poi vedere che per quel qualcuno ciò che abbiamo fatto ha un valore diverso da quello che noi gli volevamo dare (percezione). E proprio per questo era difficile lanciare il messaggio che noi volevamo lanciare senza che questo venisse visto diversamente da quello che voleva essere. Come far capire ai ragazzi il pericolo dei DCA – disturbi del comportamento alimentare – senza ferirli e magari, reazione opposta alle intenzioni, farli chiudere ancora di più in sé, farli sentire incompresi e farli allontanare? Come rendere ogni adulto più consapevole del problema e soprattutto della propria responsabilità di genitore? Come trasmettere il messaggio importante che dopo il corso avevamo appreso e volevamo mandare e condividere con gli altri?
Gli studenti e le studentesse delle classi 3A dell’indirizzo delle Scienze Umane e 5B dell’indirizzo classico, in una singolare e unica “accoppiata”, simbolo di sinergica integrazione di forze, obiettivi e finalità del Liceo manduriano, accompagnati dalle prof.sse Giovanna Caforio, Clelia Favale e Giacomina Di Noi, hanno offerto la loro proposta di “risoluzione del problema”, attraverso l’utilizzo del monologo teatrale. Quale migliore comunicazione se non quella veicolata tramite le emozioni condivise tra attori e pubblico? Quale modo più immediato, veloce, inequivocabile e forte della rappresentazione teatrale esiste? Non lo diceva forse anche Aristotele? Non lo è una prova la potenza della tragedia greca?
Ed è stato proprio così. E l’emozione provata è davvero difficile esprimerla. Forse lo si potrebbe fare solo con una parola straniera, una parola tedesca, mitgefühl, apparentemente la traduzione perfetta della nostra “compassione”, ma in realtà molto di più: mit, ovvero “con” e gefühl, “sentimento”, una parola composta; i tedeschi si divertono davvero a crearle ed hanno, secondo me, più possibilità di capire l’essere umano grazie a tutte le parole che possiedono, una per ogni sensazione, anche quelle a noi più sconosciute. Mitgefühl, con-sentimento. È qualcosa di più della con-passione, non significa provare solo il dolore dell’altro come la parola italiana ci suggerisce. Il mitgefühl è provare insieme ad una persona qualsiasi.
Erica Polito
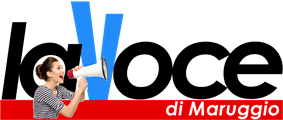 La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra
La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra 













