 Una formazione tra la teologia e la letteratura filtrata dalla filosofia di quella confessione come genere letterario alla zambraniana dimensione di un confrontarsi con le culture. È una linea portante nel solco di don Luigi Giussani, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Ho una stagione del mio vivere legato al suo modello di comparazione tra letteratura e sacro.
Una formazione tra la teologia e la letteratura filtrata dalla filosofia di quella confessione come genere letterario alla zambraniana dimensione di un confrontarsi con le culture. È una linea portante nel solco di don Luigi Giussani, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Ho una stagione del mio vivere legato al suo modello di comparazione tra letteratura e sacro.
Dialogare con don Luigi Giussani (nato a Desia il 15 ottobre del 1922 e morto il 22 febbraio del 2005 a Milano) era sempre una gioia. Spesso ci trovammo a discutere di Mario Pomilio, Diego Fabbri, Davide Maria Turoldo e poi di San Paolo. Di quel San Paolo al quale ho dedicato un libro. L’attesa e la speranza erano i nostri riferimenti anche sul piano letterario e non solo teologico. L’attesa e la speranza hanno come punto di incontro, e quindi, come punto di riferimento, il senso del religioso. Inquieta l’attesa, ma è una dimensione spirituale che avvolge le nostre coscienze. Le coscienze del linguaggio. Il linguaggio dell’essere e del non essere. Il linguaggio che è spazialità di tempo dentro una visione che va chiaramente oltre il virtuale.
Credo che la letteratura possa offrire una chiave di lettura importante e particolare del senso e dell’orizzonte che si vivono nella “stazione” di una spiritualità, che ha voce e destino. Siamo immensi nella letteratura. Siamo partecipanti del dolore che traccia un viaggio indelebile che è fatto dall’uomo e dalla persona. Poi giunse Cesare Pavese.
La letteratura parla con la parola della religiosità. Scriveva don Luigi Giussani: “Il senso religioso è la capacità che la ragione ha di esprimere la propria natura profonda nell’interrogativo ultimo, è il locus della coscienza che l’uomo ha dell’esistenza”.
Lo sguardo dell’uomo è lo sguardo, appunto, dell’attesa che, vivendola senza pazienza, potrebbe trasformarsi in disperante solitudine. Due concetti forti: la solitudine e la disperazione.
La ricerca di Dio. La memoria di Cristo. Vivono la letteratura nella letteratura. Don Giussani: “La forma quotidiana della decisione per l’esistenza è il ricordo del destino che ogni cosa ha, che è uno solo, il mistero di Dio, è il ricordo che questo mistero è diventato un uomo. Perciò, la forma quotidiana della decisione per l’esistenza è vivere la memoria di Cristo”.
Lo scavo della (nella) letteratura che trova attraversamenti su queste sponde porta direttamente a Cesare Pavese. Quel Pavese che ha vissuto e interiorizzato un dostoeschiano modello dell’inquieto esistere, e che non ha mai dato una ragione di senso alla morte sentita come attrazione della fine.
Quel Pavese, in modo particolare, che ha chiesto, sino agli ultimi istanti di vita, di superare la solitudine in una parola di consolazione e di pazienza affinché potesse giungere un barlume di luce, di Grazia, di ancoraggi.
Pavese: “Passavo la sera seduto davanti allo specchio per tenermi compagnia”.
Don Luigi Giussani stabilisce proprio con Pavese un colloquiare e dice che è mancato in Pavese ciò che potesse colmare lo spazio inevitabile tra l’attesa e la pazienza. Quando questo spazio comincia a creare una strada nella vita e negli scritti di Pavese, la luce è diventata molto fievole e quella fede che lo avrebbe potuto salvare lo trova già disperso. Disperso e non smarrito. Disperso in quel gorgo muto che è l’inevitabile nulla. Ma Pavese portava nella sua parola e nel suo sguardo un senso religioso che diventa incisivamente pietas.
Nel venir meno l’appiglio al religioso subentra l’abisso. O meglio non raggiungere il filo del sacro il vuoto si dichiara. E nell’abisso è scivolato pur tendendo le mani verso l’attrazione nei confronti della salvezza. In quale significato di non senso è precipitato Pavese? Eppure le sue ultime parole hanno un versamento che va oltre il nulla, e cercano di concentrarsi in un monito di ricerca di speranza.
Ho sempre cercato di individuare, nei miei scritti su Pavese, questo bisogno di speranza o la necessità della dissolvenza del nulla per aggrapparsi alla speranza che si sottolinea in molti passaggi dei suoi romanzi. Pavese, ho avuto modo di affermarlo, è sempre al limite della speranza – sacralità e poi giungono le distrazioni, le infinite distrazioni.
Don Giussani parla infatti di un venir meno di quella esigenza che è “la totalità dello sguardo dell’umana coscienza”. Anche nel religioso linguaggio dello scrittore ci sono delle opzioni tragiche. Ma ci sono opzioni religiose nel linguaggio e nell’essere tragico dello scrittore?
Pavese viveva la ricerca di Dio ma è andato oltre. Ecco: “La massima sventura è la solitudine; tant’è vero che il supremo conforto – la religione – consiste nel trovare una compagnia che non falla, Dio. La preghiera è lo sfogo come con un amico”.
In Pavese i due estremi di queste domande si sono scontrati creando un conflitto estetico ed esistenziale. Infatti, l’inquieto in Leopardi, don Giussani medita su ciò, non giunge a toccare il “gorgo muto” perché in Leopardi il senso del religioso non è così contrastante come nella vita di Pavese.
Tanto contrastante da diventare un cortocircuito tra destino e profezia. Così è stato il paesaggio trasgressivo di Pavese.
Don Giussani: “L’estremo lembo dell’audacia è amare umilmente se stessi”.
Il destino e la profezia. Nei suoi romanzi e nelle sue poesie ultime la consolazione giungeva sempre come solitudine. La solitudine era consolazione. Pavese si è posto le domande care a don Giussani: “… per che cosa vale la pena che io viva? Qual è il significato della realtà? Che senso ha l’esistenza?”.
Ha risposto a tali suoi interrogativi il e sia del romanzo “La casa in collina” (religiosa attrazione verso il sacro) sia, soprattutto, il Pavese di “Verrà la morte e avrà i tuoi occhi” (penitente accoglienza della morte – fine).
Gli occhi? Quegli occhi che ha sempre cercato e che non ha trovato o non ha avuto la pazienza di aspettare quegli Occhi. Il rischio della pazienza consiste nel non saper raccogliere l’attesa nella speranza. Forse è qui che bisognerebbe scavare per dare un senso all’uomo e allo scrittore Cesare Pavese. Oltre il mito e molto più vicini al sacro.
Pierfranco Bruni
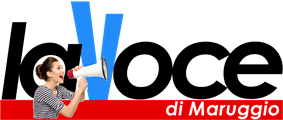 La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra
La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra



