
Mio padre (e quasi tutti i papà di coloro che hanno la mia età) non ha mai voluto raccontarmi com’era stata la sua vita da bambino-contadino. Non ha mai voluto raccontarmi com’era stata la vita di suo padre contadino e di sua madre anch’ella contadina. Forse per pudore o per vergogna. Vergognarsi di che o di cosa, poi? Non ha mai voluto dirmi che nelle famiglie contadine come la sua si correva e si invecchiava precocemente perché si era adulti a otto anni e maturi a quattordici. «I bambini» (come mio padre) – è scritto nel “Cristo si è fermato a Eboli” – «avevano qualcosa di singolare (…). Erano chiusi, sapevano tacere, e, sotto l’ingenuità infantile, c’era l’impenetrabilità del contadino, sdegnosa di impossibili conforti, il pudore contadino, che difende almeno l’anima in un mondo desolato. Erano, in generale, molto più intelligenti e precoci dei ragazzi cittadini della loro età: rapidi nell’intuire, pieni di desiderio di apprendere e di ammirazione per le cose ignote del mondo di fuori.»
Ci sono voluti anni perché io capissi, senza il suo aiuto, che il mestiere più diffuso e meno amato è stato sempre quello dei contadini. Era ed è un lavoro duro, lungo e faticoso. Quello di mio nonno prima e quello di mio padre poi era un miserevole mestiere per quattro miserevoli lire. Si nasceva contadini e si moriva contadini. Come i briganti. Egual destino: mio padre e suo padre sono morti contadini.
La sua non è stata una infanzia rubata, ma una età adulta anticipata. L’esatto contrario di oggi.
Tonino Filomena
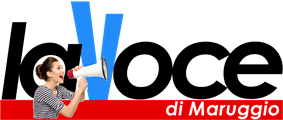 La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra
La Voce di Maruggio Informare, Unire, Valorizzare la Nostra Terra



